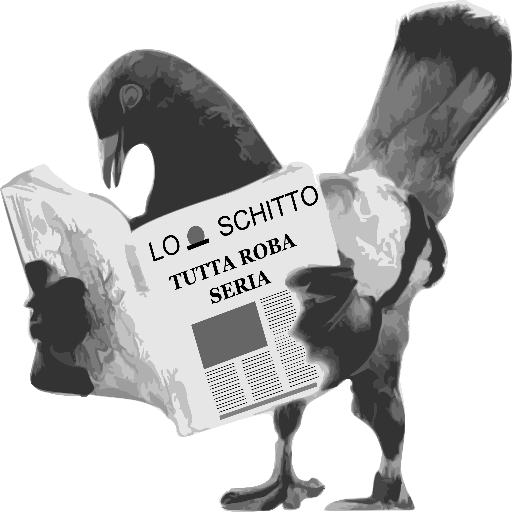
Il potere logora (la stampa)
13 Aprile 2017
Un dilettante allo sbaraglio alla Casa Bianca
28 Aprile 2017Populismo: una definizione molto diffusa, e usata molto spesso in politica a sproposito o impropriamente, data l’insita vaghezza del termine e data la sua acquisita valenza svalutativa.
All’inizio, al suo nascere, fu un movimento associato ad intenti umanitari, al fine di migliorare le condizioni di vita di una popolazione, ed ebbe origine in Russia; fu combattuto dal movimento comunista, in quanto ritenuto disorganizzato e velleitario.
Tracce di populismo si rinvengono nei regimi totalitari del ‘900 per rinsaldare l’identificazione tra la massa e il leader supremo. Caratteristiche di populismo si ritrovano in paesi in cui un movimento politico, con un leader, si proponeva di scardinare lo status politico-economico vigente; un leader che avrebbe interpretato e attuato le aspirazioni di riscatto e di “giustizia” della parte più svantaggiata della popolazione. Si pensi al movimento Justicialista di Peròn in Argentina, e più recentemente alla politica di Chavez in Venezuela.
Il fenomeno populista in Italia si è posto all’attenzione con il successo elettorale del M5S, che per svariate caratteristiche si può considerare un modello di movimento populista. Tuttavia il fenomeno populista non nasce all’improvviso. Il populismo si accompagna alla crisi dei partiti tradizionali; è stato preceduto dalla diffusione di formule ambigue celebranti l’antitesi tra “paese reale “, grande comunità supposta nel suo insieme virtuosa, e “paese legale”, quello della classe politica generalmente corrotta e inaffidabile; si ricordi negli anni ’80 il movimento “Società civile”, lanciato da Nando Dalla Chiesa; la Lega degli esordi, con i suoi slogan contro Roma ladrona ed il potere centrale; Berlusconi contro i politici di carriera “che non hanno mai lavorato”; i fortunati libri che hanno segnalato i privilegi della “casta”, politica e sindacale. Ricordiamo il drastico “vaffa-day” organizzato da Beppe Grillo, la sua contrapposizione feroce alla classe politica. Un fenomeno, quello populista, favorito anche dalla lunga serie di processi mediatici che tanto successo e sostegno hanno riscosso nell’elettorato di sinistra.
Ma più che a tracce o singole manifestazioni di populismo, riferiamoci ai movimenti che presentano stabilmente, nella loro ispirazione e nella loro attività, caratteristiche di populismo, nel periodo contemporaneo. E’ un termine, il populismo, che si presta a varie definizioni, forse troppe, tant’è che Ilvo Diamanti lo descrisse qualche anno fa come una “definizione indefinita”.
Da alcuni il populismo è stato identificato come il rapporto diretto tra un leader e la massa di sostenitori, ma è una identificazione impropria. Non è questo l’elemento principe. A mio avviso non è definibile come populismo il solo rapporto diretto tra il leader e la massa; è questo un rapporto per certi versi inevitabile nella nostra epoca, complice la perdita di efficienza e di attrazione degli apparati intermedi di partito. Già anni fa dai politologi era stata prefigurata, in Italia, la crescita di attrazione dei leaders di partito (ricordo “Il capo carismatico” di Luciano Cavalli, e “Leadership e democrazia”, raccolta di contributi, curata da Cavalli, allo studio della leadership nella democrazia contemporanea); e successivamente era stato descritto il processo di personalizzazione in corso (ricordo il libro di Mauro Calise “Il partito personale”). Studi e ricerche accompagnati, per contro, da avversione diffusa verso quei leaders che sembravano concretizzare questo tipo di rapporto diretto; una avversione manifestata per lo più in osservanza agli schemi partitici tradizionali che prevedevano, nella formulazione della linea nazionale, la mediazione tra correnti interne, o le risoluzioni del Comitato centrale.
Tornando alle definizioni, il populismo può essere considerato anche come una strategia, scientemente messa in atto per espandere il sostegno del leader tra le masse ed i ceti sociali medio-bassi, come negli esempi latinoamericani. Una delle definizioni più interessanti ritengo sia quella del politologo olandese Cas Mudde, che definisce il populismo una ideologia “debole”, cioè non articolata, che si basa su una contrapposizione schematica tra il popolo innocente e le élites corrotte che quel popolo hanno tradito. A differenza della democrazia, che racchiude pluralità di interessi e motivazioni, afferma Mudde, il populismo non contempla questa pluralità; per il populismo il popolo è una entità omogenea, ed è puro e portatore di valori; quindi il populismo rimanda ad una idea morale, laddove nel contesto democratico il popolo non detiene una morale particolare.
Il populismo nel suo furore anti élites si serve dunque della morale, una morale non circostanziata, estremamente adattabile, che serva a individuare come nocivi per il popolo anche provvedimenti che esulano da ambiti morali: per esempio la campagna da parte del M5S per l’uscita dall’euro, polemica tecnicamente di natura economica, ma caricata di senso morale in quanto la decisione di entrare nell’euro fu presa da élites considerate antipopolari e corrotte.
Si può dire che il populismo rappresenta una vera e propria frattura. Una contrapposizione radicale nei confronti delle élites, che del populismo sono le naturali entità antagoniste. Il che non è poi tanto lontano dall’avversione nei confronti dei cosiddetti poteri forti, dei poteri occulti, molto diffusa a sinistra; soprattutto quando è difficile individuare l’antagonista, o l’antagonista è molteplice, ed è complicato e faticoso per il cittadino acquisire lucide analisi. Non a caso il credo populista indulge nelle visioni complottiste. Quindi la frattura anti-élites oscura le altre fratture presenti nella società, mette in risalto una dicotomia omnicomprensiva e totalitaria, quella tra governanti e cittadini, di facile alimentazione, di antico fascino e dotata di notevole forza d’urto.
Le condizioni favorevoli su cui il populismo può contare sono date dalla crisi dei partiti e dei corpi intermedi, infatti, almeno nella fase storica contemporanea, il rapporto di empatia e identificazione si instaura tra la massa ed un leader carismatico. Il populismo è un meccanismo di dis-intermediazione, oltre che le élites disprezza gli apparati di intermediazione, siano partitici, sindacali, economici, professionali.
Infine, il populismo di oggi si avvale di un potente mezzo di diffusione, la rete, con la sua pervasività e la sua velocità; un aspetto rilevante, di enormi implicazioni, su cui sarà opportuno ritornare.



