
I signori della guerra
6 Ottobre 2025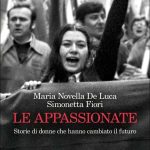
Le appassionate di Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori
9 Ottobre 2025Grande confusione sotto il cielo del mondo, grande confusione sotto quello Europeo e grande confusione anche nelle stanze dei partiti politici europei, smarriti, nel migliore dei casi, dentro la realtà che dovrebbero governare.
Una veloce panoramica sul contesto europeo unita all’indicazione delle cause di questo smarrimento può aiutare ad aprire la strada a qualche proposta.
Nell’attuale scenario, i più smarriti sono i partiti di centro sinistra, forse perché quelli conservatori meglio convivono nell’odierna post-democrazia di cui ho già parlato in un precedente articolo apparso su questa testata (“L’Europa davanti allo spettro della post democrazia).
Solo pensando alla Francia la crisi del partito gollista da sempre espressione del sentire della borghesia e delle sue tradizioni ben si accompagna a quella del partito socialista dove i tempi di Mitterand sono ormai un ricordo lontano e il rischio vero, per i socialisti, è quello di essere scavalcati a sinistra dal populismo di Mélenchon.
E al centro? Per ora nulla, considerato che l’encomiabile tentativo di Macron di costruire una forza centrista e progressista non sembra essere riuscito mentre chi si sta rafforzando è Rassemblement National della famiglia Le Pen anche grazie al sostegno di finanzieri come Vincent Bolloré.
Le cose non vanno del tutto meglio in Germania dove alle elezioni di febbraio, il partito Socialdemocratico è passato dal 25,7% al 16,4% e, dato ancor più preoccupante, Alternativa per la Germania (AfD), un partito di estrema destra, ha ottenuto il 20,8% collocandosi subito dopo l’Unione di centro-destra CDU-CSU che resta ancora il primo partito con il 28,5% dei voti. Lo scenario al centro è deprimente se pensiamo che il partito liberale (Freie Demokratische Partei) è rimasto addirittura fuori dal Parlamento.
La Gran Bretagna (un piede, o qualcosa di più è per fortuna ancora ancorato nel Vecchio Continente) vive un certo malessere dovuto essenzialmente a sondaggi (quelli che Shimon Peres paragonava ai profumi “si annusano ma non si bevono”) secondo i quali sarebbe inarrestabile l’ascesa della destra populista di Reform UK dell’ineffabile Nigel Farage intento a demolire il rinnovamento graduale dei laburisti di Starmer.
L’Italia, quel “povero paese” come venne definito da De Gaulle è oggi governata da tre partiti di cui almeno due di destra, euroscettici quanto basta, che hanno gioco facile davanti, da una parte, a un centro dove esistono (contate) almeno 16 personalità ognuna riconducibile ad una sigla più o meno grande (unirsi no?), dall’altra a un partito democratico che non ha fatto ancora pace dentro sé stesso e, a volte, nemmeno con i propri alleati.
Marco Damiani già nel 2023 sul “Mulino” (La crisi della sinistra europea) aveva individuato quattro possibili cause che, sebbene riferite espressamente alla crisi della sinistra, oggi, a ben guardare hanno a mio avviso molto in comune con la generale crisi dei partiti storici.
Si va dalla 1) fine di una coscienza collettiva europea, un tempo in grado di esprimere soggetti politici, passando per 2) la “forte accelerazione del cosiddetto processo di individualizzazione sociale” che caratterizza anche la società europea 3) il “Cultural backlash” (contraccolpo culturale) relativo al sentimento di insicurezza che i processi di globalizzazione internazionale hanno determinato sulle persone, arrivando fino alla 4) quarta e ultima ragione connessa alla rivoluzione informatica e tecnologica, che ha ridotto le potenzialità dei partiti di operare come erano abituati a fare.
Le cause appena citate, per ragioni di sintesi non possono essere approfondite o ampliate come potrebbero ma è certo che ognuna di esse coglie in modo evidente il ritardo accumulato dai partiti tradizionali nel mettersi in sintonia con i problemi della realtà europea, non per forza riconducibili a “massimi sistemi” anzi, i nuovi movimenti politici negli ultimi tempi all’inizio hanno preso forma a livello locale.
Da qui l’idea, certo non del tutto nuova, di chiedere agli storici partiti europei di valutare la possibilità di dare vita a un raggruppamento europeo considerato peraltro come i temi delle agende politiche coincidano sempre meno con i confini nazionali e siano sempre più trasversali.
In tal senso perché non iniziare questo percorso di rottura e di fuoriuscita dagli schemi proprio dalle elezioni amministrative candidando tra le fila dei partiti tradizionali chi, pur non essendo originario del paese o della città in cui si va al voto è un cittadino europeo che vive e conosce (a volte meglio degli autoctoni) i problemi del territorio che abita.
Oggi, infatti, in tutta Europa, uscire dagli schemi, sperimentare strade nuove, è forse una delle ultime possibilità che i partiti conservatori, liberali e socialisti hanno se vogliono continuare a vivere facendo onore alle loro storie.



