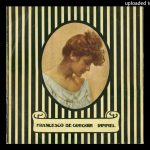
Rimmel, cinquant’anni fa, controcorrente nel decennio di piombo
1 Gennaio 2025
Ancora sulla vexata quaestio del Centro
7 Gennaio 2025Ho pubblicato qualche tempo fa un breve articolo su un argomento del quale avevo una conoscenza un po’ sommaria. Tuttavia, ai fini del succinto discorso che facevo non mi serviva affatto di averne una accurata. Non dirò quale fosse l’argomento, perché la cosa non solo non è rilevante, ma anzi sarebbe fuorviante ai fini delle considerazioni che mi appresto a fare.
Ebbene, a causa di tale articolo ho ricevuto, da parte di un lettore, un’aspra reprimenda. L’accusa è stata, in breve, quella di aver parlato superficialmente di qualcosa che non conoscevo bene, senza previamente documentarmi, senza aver prima consultato un’idonea bibliografia, e senza supportare il mio discorso con conoscenze “scientifiche”. Le quali ultime, a onor del vero, non è che servissero granché nel caso in specie e non è che servano sempre.
Sta di fatto che l’anzidetta reprimenda mi offre il destro per condurre una riflessione più generale su una questione a cui ho spesso pensato. In linea di massima, infatti, convengo anch’io sull’opportunità di parlare (e scrivere) di cose che si conoscono e su cui si è informati oppure sulle quali, almeno, ci s’informa prima di parlarne o di scriverne. Del resto, è quello che personalmente faccio quando mi appresto a scrivere su un argomento che m’interessa, sì, ma che non conosco bene. Meglio sarebbe addirittura parlare di cose su cui si abbia una competenza specifica. Tuttavia…
Tuttavia, sarà proprio vero in ogni caso che si debba parlare solo ed esclusivamente di cose sulle quali si abbia una conoscenza peculiare e magari professionale? È necessario sempre e per ogni argomento documentarsi prima su libri o su altre fonti scritte e autorevoli? Vediamo. Un ciabattino che abbia svolto per tutta la vita il mestiere di calzolaio, avrà titolo per esprimere, anzi, per avere opinioni (se non addirittura per pensare) solamente di suole, di tacchi e di tomaie? Oppure, che so, un elettricista potrà dire la propria solo su resistenze, interruttori e circuiti? E se non fa questo e parla d’altre cose, è inevitabile che dica sciocchezze?
Non credo. Si dà il caso, infatti, che tutti noi, come persone, come esseri umani e, in specie, come cittadini, siamo chiamati spesso a dire la nostra anche su materie che esulano dalle nostre competenze e dalle nostre conoscenze professionali o di mestiere. È giocoforza che sia così. Un solo esempio. Quando esprimiamo uno voto politico o quando andiamo nell’urna per un referendum, dovremmo pure aver cercato di formarci un’opinione. Come membri di una collettività siamo tenuti a pensare ed anzi avremmo il diritto-dovere di farci un’opinione ed anche di essere liberi di esprimerla.
Del resto, i giornalisti non sono spesso chiamati a scrivere sui temi più disparati, senza poter certo avere conoscenze universali? È inevitabile che sia così. I parlamentari, poi, dal canto loro non sono forse tenuti ad esprimersi, per votare e per legiferare, su qualunque materia, anche se nella loro precedente vita hanno fatto solo il mestiere di medici o quello, che so, di assicuratori? Non sono certamente dei tuttologi, ma è inevitabile che le cose vadano così.
Tuttavia, fermo restando il principio sacrosanto che è meglio non parlare (e non scrivere) di ciò che non si conosce, e pur plaudendo al criterio generale che prima di dire la propria su un argomento è preferibile documentarsi, tuttavia… Tuttavia le “fonti” del nostro sapere di esseri umani non è mica detto che debbano essere (e di fatto siano) esclusivamente i libri, i saggi, i trattati, le dissertazioni e gli interventi degli specialisti.
Le risorse anche solo di tempo e gli impegni della vita quotidiana non consentono a molti (ma direi a tutti) d’informarsi su ogni cosa. D’altro canto, ci sono molte “materie” che ciascuno di noi conosce e comprende anche in assenza di una preparazione specifica. Ci sono tanti argomenti – come dire – aspecifici, per i quali ciascuno di noi attinge, inevitabilmente al “grande libro della vita” e all’esperienza della propria esistenza. Ci sono conoscenze che s’apprendono anche senza libri e sulle quali ci si forma un pensiero, un’opinione fondata. Non ”scientificamente” fondata, forse, ma fondata. Ci sono argomenti, insomma, sui quali è possibile esprimere giudizi interessanti e di valore. A condizione, beninteso, che uno sia capace di esprimerli…
E infatti, l’importante, credo, è che chi argomenta, chi produce un discorso, sia prudente e cauto, cerchi di eludere gli scogli degli svarioni e degli azzardi, che il suo dire schivi le affermazioni troppo perentorie e che i giudizi siano espressi con un certo beneficio d’inventario; e soprattutto che il suo discorso si attenga alla coerenza ed alla consequenzialità.
Può succedere allora che questo tale, sia pure nel breve spazio di un testo giornalistico, di un semplice articolo, di un breve intervento orale, di un’opinione espressa a voce, può essere che riesca a dire cose sensate che meritano di essere dette, ascoltate, lette. Perfino nell’ipotesi che non si tratti di uno specialista d’alcunché, può darsi che qualcosa d’interessante da dire su argomenti che sono magari sotto gli occhi e l’esperienza di tutti (ma che non tutti vedono), uno ce l’abbia anche senza aver letto e studiato tanto.
E può anche darsi che costui sappia farlo, puta caso, meglio di un esperto, il quale, per quanto esperto, magari è esperto poco o niente in comunicazione (càpita) o più semplicemente zoppica nella lingua italiana oppure (peggio mi sento) nella capacità di farsi comprendere e di esporre le cose (a chi non le conosce o non le ha comprese), cioè che difetti della virtù di farsi intendere e di venire al più presto al punto di ciò che intende dire.
I cosiddetti esperti, non di rado, non sono capaci di farsi capire: parlano “latinorum”, parlano criptico, con parole note solo agli addetti ai lavori, con discorsi affollati di tecnicismi, di sigle e di anglicismi, spesso peraltro inutili. Si dà il caso che sovente il compito di fare intendere cose difficili al vasto pubblico degli uomini della strada, spetti ai divulgatori, cioè a coloro che s’incaricano di rendere digeribile ai più anche materie e argomenti ostici o poco noti. È proprio attraverso i divulgatori (purché non siano dei “banalizzatori”) che si attua quella “educazione permanente del cittadino” della quale, ahimè, non si parla più tanto. E, per intenderci, faccio solo due nomi tra i non molti, purtroppo, che si possono fare in Italia: Piero Angela e Alessandro Barbero.



