
ANIMALS Essere animali a Gaza
26 Luglio 2025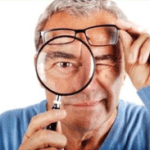
Spigolature
28 Luglio 2025Nonostante il titolo, La sindrome di Gaza, il nuovo romanzo di Maria Grazia Gagliardi non ci porta in un territorio di guerra come ci si aspetterebbe, ma dentro una storia d’amore.
I due protagonisti, Amelio ed Elena, travolti dalla passione, sono allo stesso tempo attraversati dal dilemma morale su quale debba essere il ruolo di chi proviene da un mondo ancora prospero, di fronte alla tragedia del popolo palestinese.
Scritto subito dopo l’operazione Piombo Fuso, l’offensiva militare lanciata da Israele contro Gaza tra il 28 dicembre 2008 e il 19 gennaio 2009, il romanzo è diviso in capitoli che seguono l’andamento della guerra. Ogni capitolo corrisponde a una giornata ed è introdotto dai titoli dei giornali dell’epoca, riportati senza indicazione della testata.
Per Amelio, quelle cronache risvegliano il ricordo della morte della madre, avvenuta quando era bambino, negli stessi giorni del massacro di Sabra e Shatila.
Davanti a quelle immagini di distruzione, ai volti dei bambini, come lui, rimasti senza più una madre, aveva sentito una sorta di fratellanza con le popolazioni straziate.
A quella prima esperienza della morte risale il suo digrignamento cronico, la contrazione involontaria della mascella che fa stridere i denti.
Amelio assume su di sé il male del mondo – i bombardamenti, gli amputati, i senza casa, gli orfani – e lo sovrappone al proprio dolore.
Questo intreccio tra la dimensione collettiva e quella personale si incarna nel corpo, esplodendo in fitte mandibolari “come se un chiodo lucente lo perforasse”. Un dolore così acuto che “avrebbe potuto gridare o mettersi a piangere, eppure così rapido che riusciva a far finta di niente.”
Il suo bruxismo degenera fino a sfociare in una condizione al limite della patologia: la sindrome di Gaza, espressione coniata dalla giornalista israeliana Amira Hass nel 2009 per descrivere l’empatia per la sofferenza del popolo palestinese.
Nel romanzo, Amelio diventa il “digrignatore”, marchiato da un dolore che non lo abbandona.
Anche Elena digrigna i denti, ma solo occasionalmente. Il suo digrignamento è passeggero, ma sufficiente perché Amelio vi riconosca un’affinità e ne resti attratto.
I due si conoscono durante un viaggio di lavoro in Medio Oriente per conto di un’agenzia di statistiche che valuta i dati dei Paesi del Terzo Mondo. Le loro giornate sono segnate dal confronto con numeri che, anche se “non ammettono disquisizioni”, sono condizionati dal metodo con cui vengono raccolti e possono produrre risultati distorti. Alla lotta per la verità di Elena, corrispondono lo scetticismo e la rassegnazione di Amelio. Amelio ed Elena non sono solo due individui, ma simboli di atteggiamenti opposti di fronte alle tragedie umane.
I loro rituali notturni sono pervasi da una passione impetuosa, e persino da un potenziale aggressivo; le loro bocche, dai denti frastagliati, hanno qualcosa di ferino, possono rivelarsi fauci pericolose: “Elena digrigna i denti e, come lui, può azzannare.”
La ferocia della guerra si riflette, sottile e latente, nel rapporto tra i due protagonisti, sempre in bilico tra tenerezza e aggressività. Il bruxismo esprime una rabbia repressa, una tensione che cerca una via d’uscita.
Il nome “Amelio” deriva dal greco ameleia, assenza di cura. Il protagonista appare come il prigioniero di un destino già segnato. Eppure, per sottrarsi a questa condanna di non-curanza implicita nel suo stesso nome, l’unico modo è capovolgerla e agire.
Alla noncuranza si può rispondere solo con l’attenzione verso il mondo. Prendersi cura degli altri significa, in fondo, prendersi cura di sé, in un rapporto di reciprocità: stare nel mondo non solo per se stessi, ma anche per gli altri.
Amelio è l’antieroe che rappresenta un’angoscia diffusa che non riguarda solo i singoli, ma si estende a intere comunità che, in un’epoca segnata dalla crisi dei grandi sogni collettivi, restano schiacciate dal peso di guerre, catastrofi climatiche e ingiustizie evidenti.
Il romanzo di Gagliardi è breve, ma la sua sintassi è densa, la scrittura elegante, le descrizioni compatte e il tono spesso poetico.
La sindrome di Gaza non ci mette di fronte alla guerra dei carri armati, delle esecuzioni, del sangue e della fame, che pure rimangono latenti nel lettore, ma a un conflitto molto più interiore.
È un romanzo che ci interroga fino a che punto riusciamo a spingerci con la nostra etica per incidere sul mondo, ciascuno a modo proprio. Perché ogni piccolo gesto è comunque un gesto necessario.
La sindrome di Gaza di Maria Grazia Gagliardi
AStARTE, 2025



